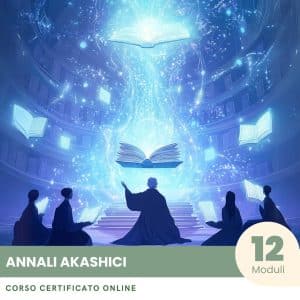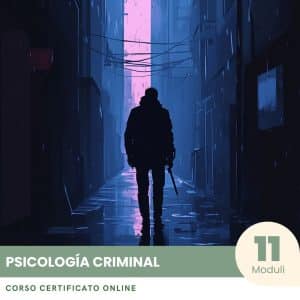1-4 – Principi etici e deontologici fondamentali
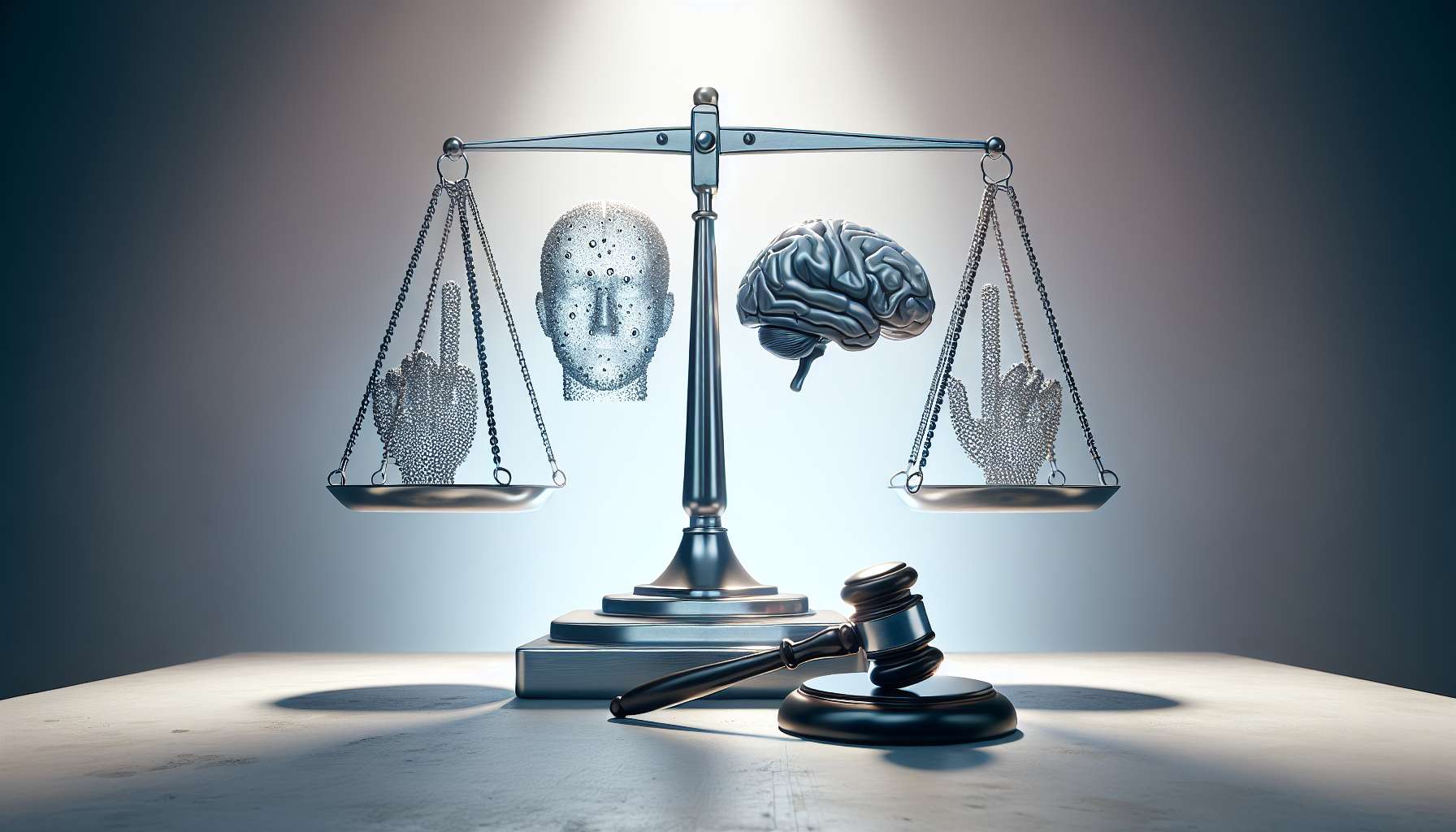
La psicologia criminale, in quanto disciplina scientifica, non può fare a meno di una riflessione approfondita sui dilemmi etici e deontologici che solleva. Studiare la psiche degli autori di atti delittuosi o violenti colloca i ricercatori e i professionisti di fronte a dilemmi morali complessi. Come conciliare il rispetto della dignità delle persone, il dovere di non nuocere e l’esigenza di protezione della società? Quali sono i limiti da non superare nell’investigazione psicologica dei processi criminali? Queste domande devono essere al centro delle preoccupazioni di ogni psicologo che opera nel campo criminologico.
Un primo principio cardinale è quello del rispetto incondizionato della dignità umana. Le persone autrici di reati, anche i più gravi, non perdono mai la loro qualità di essere umano e i diritti fondamentali ad essa associati. Lo psicologo deve preoccuparsi di non ridurle mai ai loro atti, di non disumanizzarle o stigmatizzarle. Ciò implica mantenere sempre una postura empatica, cercando di comprendere il loro funzionamento nella sua globalità, senza giudizio morale. Questo atteggiamento di considerazione è essenziale non solo dal punto di vista etico, ma anche per stabilire un’alleanza di lavoro favorevole all’evoluzione psicologica.
Tuttavia, questa empatia non deve far dimenticare la sofferenza delle vittime e l’imperativo di protezione della società. Lo psicologo in criminologia deve trovare un equilibrio delicato tra benevolenza nei confronti degli autori e lealtà verso le istituzioni giudiziarie e penali. Quando identifica un serio rischio di recidiva, ha il dovere di informare le autorità competenti, anche se ciò può andare contro gli interessi immediati della persona seguita. Allo stesso modo, deve resistere a qualsiasi pressione volta a minimizzare la gravità dei fatti o la pericolosità di un individuo. La sua etica professionale lo obbliga a rimanere obiettivo e a fornire un’illuminazione clinica rigorosa ai decisori.
Un altro tema importante è quello del consenso libero e informato. In psicologia criminale, le persone sono spesso costrette legalmente a sottoporsi a una valutazione o a un monitoraggio. In questo contesto, si può davvero parlare di consenso? Lo psicologo deve assicurarsi che la persona comprenda gli obiettivi e i limiti del suo intervento, che non sia soggetta a pressioni esterne indebite. Deve anche prestare attenzione a non oltrepassare il suo mandato legale, a non utilizzare la costrizione come leva per ottenere informazioni che non sarebbero fornite spontaneamente.
La questione della riservatezza si pone anche con particolare acuità. Il segreto professionale può essere sollevato quando sono in gioco interessi superiori, come la protezione delle persone. Ma questa revoca deve rimanere eccezionale e proporzionata. Lo psicologo può rivelare solo gli elementi strettamente necessari per prevenire un pericolo, senza svelare l’interezza delle confessioni ricevute. Deve anche informare le persone seguite sui limiti della riservatezza, sui casi in cui potrebbe essere chiamato a trasmettere informazioni alla giustizia.
Al di là della pratica clinica, i ricercatori in psicologia criminale si trovano di fronte a dilemmi specifici. Alcune ricerche, per le tematiche trattate o le metodologie impiegate, possono comportare rischi per i partecipanti o la società. Interrogare gli autori sui loro vissuti di atti violenti può riattivare impulsi o generare stati di disagio. Analizzare dettagliatamente il modus operandi dei criminali può dare “idee” a individui malintenzionati. I ricercatori devono quindi ponderare con la massima rigore i benefici attesi e i potenziali rischi dei loro protocolli. Hanno la responsabilità di inquadrare rigorosamente i loro lavori sul piano etico.
Questa vigilanza deve esercitarsi anche nella comunicazione dei risultati. La tentazione può essere forte, di fronte a crimini che suscitano una forte indignazione sociale, di esprimere opinioni riduttive o stigmatizzanti. Spiegare non è scusare, comprendere non è giustificare. I ricercatori devono prestare attenzione a non far strumentalizzare i loro lavori a fini di sicurezza o politici. Devono ricordare incessantemente la complessità dei processi studiati, i limiti delle conoscenze stabilite, per evitare qualsiasi generalizzazione abusiva.
Infine, un principio deontologico spesso trascurato è quello della riflessività. Di fronte alla violenza e alla trasgressione, lo psicologo non è un osservatore neutro e distaccato. Ha le proprie rappresentazioni, le proprie risonanze emotive, che possono distorcere il suo giudizio o disturbare la sua relazione con le persone seguite. Un lavoro di elaborazione sul proprio rapporto con la delinquenza, la sanzione, l’influenza è indispensabile. Questa riflessività passa attraverso un’analisi della propria pratica tra pari, una supervisione regolare, se non un lavoro terapeutico personale.
L’etica e la deontologia non sono dunque un’aggiunta alla psicologia criminale, ma ne costituiscono le fondamenta e la bussola. In un campo in cui le trasgressioni e la sofferenza psicologica sono onnipresenti, in cui le aspettative sociali e le pressioni istituzionali sono forti, una riflessione costante sui temi e sui limiti della propria azione è indispensabile. Solo questa domanda esigente può consentire agli psicologi di condurre un’azione criminologica sia efficace che rispettosa delle persone, socialmente utile e scientificamente inossidabile.
👉 Per scaricare il file docx (modificabile), clicca qui: Clicca qui
👉 Per scaricare il file PDF, clicca qui: Clicca qui
👉 Per scaricare il file MP3, clicca qui: Clicca qui